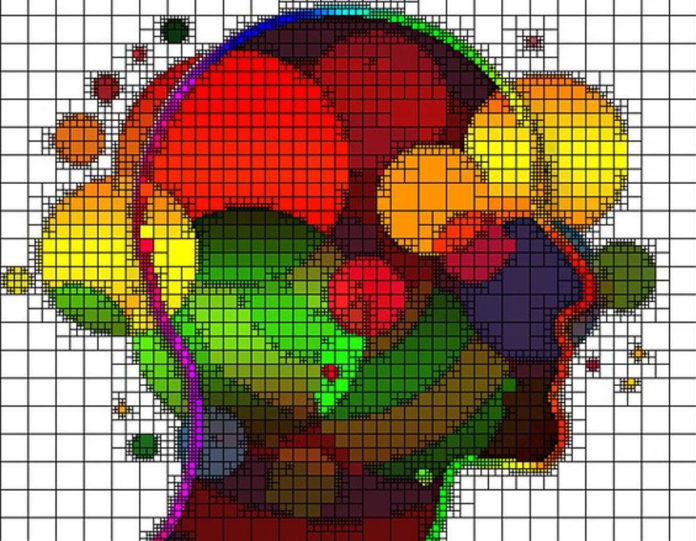Serve un cambio di marcia
Imparare a conoscere le sostanze che ci fanno vivere e distinguere quando inquinano. Spesso la comunicazione dei media si concentra solo sulle campagne di propaganda di associazioni varie, incomplete, asistematiche, saltuarie e prive di verifica alcuna, presentandole come «il termometro dello stato di salute» delle nostre acque. Il risultato sono allarmi talvolta strumentali, e comunque della durata di poche ore, e nessuna attenta analisi di sistema su cui sarebbero grandi e medi programmi di intervento nazionali e regionali a essere utili e necessari
- Articolo di presentazione
- F. Boero: Ambiente e politica, un’unione contronatura?
- M. Blonda: 15 anni fa… «quando c’era una speranza, o almeno ci credevo»
- Non è più tempo di scorciatoie
Fluoro, Iodio, Selenio e Silicio, Cromo, Cobalto, Ferro, Litio, Manganese, Molibdeno, Nichel, Rame, Stagno, Vanadio e Zinco. Quanti di questi ci fanno paura, percepiti come pericolosissimi inquinanti? Eppure sono tutti essenziali per la nostra sopravvivenza. Svolgono un ruolo insostituibile nel metabolismo umano e della biosfera in genere. Ad altri elementi della famosa «Tavola Periodica» siamo solo «adattati», cioè il nostro metabolismo sa come renderli innocui. Di altri ancora ci serviamo addirittura come medicine.
Allora perché li ritroviamo anche nelle tabelle delle norme ambientali, al punto da portare a volte al divieto di bere un’acqua o di coltivare un terreno o di mangiare una partita di pesce?
È tutto un problema di quantità, cioè di concentrazione. Oltre un certo limite terminano innocuità e benefici per noi e iniziano rischi e danni; è allora che usiamo la parola inquinamento. Per gli ecosistemi «estremi», invece, altissime concentrazioni possono essere funzionali. Solo che quegli ambienti non sono adatti a noi, cioè sono inquinati, dal nostro punto di vista. Questo è banale, si dirà, e non serviva tutta questa scienza per ricordarcelo.
Basti pensare che per bloccare i batteri che possono far andare a male la frutta o carne e pesce, da millenni si usano cose innocue, come lo zucchero o il sale da cucina, ma molto concentrati. Le marmellate non sono forse «conserve» di frutta che impiegano questo principio? Il punto è che la natura aveva fatto in modo che, negli ambienti non estremi, di alcuni elementi circolassero solo tracce in forma disponibile e assimilabile, quelle necessarie o sopportabili. Noi, per i nostri impieghi, li estraiamo a forza e li «concentriamo», e dopo l’uso li disperdiamo nell’ambiente in vario modo, ma sempre «concentrati». E il pasticcio è bello e fatto.
Quindi l’inquinamento da elementi chimici non è quasi mai solo la sua presenza, ma sempre il suo eccesso di concentrazione rispetto a limiti teorici che noi stessi fissiamo. Allora nessun allarme se dalle analisi del mare dove facciamo il bagno, ad esempio, compare l’arsenico; il problema nasce solo se ce n’è troppo, segno di un’alterazione che quasi sempre è causata da noi. Poi ci sono i composti e i materiali creati ex novo dall’uomo, volontariamente o no: dai pesticidi ad alcune diossine (sottolineo alcune) o altre molecole dette xenobiotiche. Questi, per la natura, sarebbero inquinanti per forza, visto che per milioni di anni non li aveva previsti per nulla. Eppure ne sopportiamo tracce e residui, per quanto molto bassi, anche ai sensi di legge, senza che scattino allarmi e misure protettive.
La moderna Ecologia tende a superare questi paradossi, proponendo un approccio valutativo agli ecosistemi molto più complesso del metodo basato su secchi limiti tabellari, ma al tempo stesso molto più coerente con la realtà complessa che si studia o si analizza: la valutazione dello stato di qualità.
Questo approccio ha anche fatto breccia nella normativa comunitaria, per ora applicato solo al monitoraggio delle acque superficiali (non ancora a quelle sotterranee o al suolo), con l’emanazione della Direttiva Acque del 2000, recepita nel Testo Unico ambientale italiano, il 152 del 2006.
In base alla norma, infatti, i corpi idrici superficiali (acque marino-costiere, acque di transizione, fiumi e bacini) vengono sistematicamente monitorati per centinaia di parametri, poi elaborati in forma integrata a definire uno stato di qualità. Le Regioni, sulla base dello stato riscontrato, devono poi adottare misure di tutela o di intervento migliorativo, per elevare lo stato di qualità ove non già buono.
L’attuale banca dati in possesso del Ministero, prodotta dal Sistema nazionale per la protezione ambientale (Ispra e le Arpa), è già immane, e non nasconde le maggiori criticità esistenti o le eccellenze che ci rimangono. Ma quasi sempre la comunicazione dei media si concentra solo sulle campagne di propaganda di associazioni varie, incomplete, asistematiche, saltuarie e prive di verifica alcuna, presentandole come «il termometro dello stato di salute» delle nostre acque.
Nulla di più sbagliato, come è evidente; il risultato sono allarmi talvolta strumentali, e comunque della durata di poche ore, e nessuna attenta analisi di sistema su cui sarebbero grandi e medi programmi di intervento nazionali e regionali a essere utili e necessari. Al solito, quando l’alternativa è sudore ai fornelli, il precotto colorato a porzione è preferito. E tutto resta com’è, dopo milioni di euro gettati al vento in monitoraggi sistematici ufficiali.
Saranno forse i cambiamenti climatici, col loro tremendo impatto sulle acque, a costringerci a tornare all’attenzione vera alle risorse? Non si sa; certo è che se smettessimo di parlare solo di inquinamento e ci interessassimo di più alla sostanza dei fenomeni, forse all’arrivo delle catastrofi potremmo farci trovare più preparati.
Massimo Blonda, Biologo Ricercatore Cnr